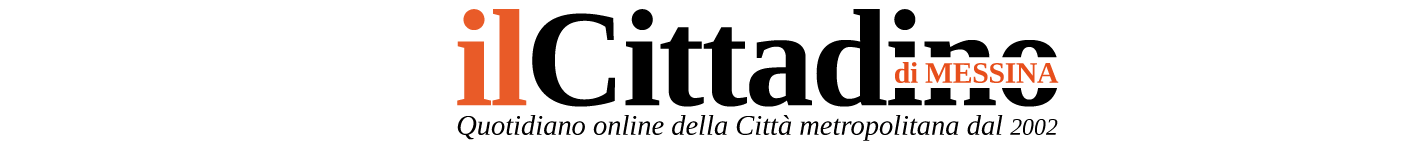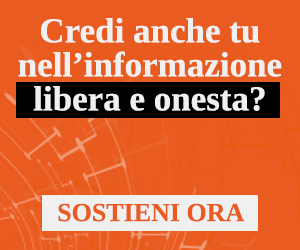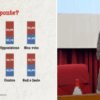A seguire le riflessioni dell’Ing. Francesco Cancellieri (Foto)– Presidente AssoCEA Messina APS e Responsabile Nazionale Area Tematica SIGEA-APS “Paesaggi, Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000”:
Dentro una scatola piena di luce!
Immaginiamo questa “disputa” come un dialogo tra due giganti (Niels Bohr e Albert Einstein) del pensiero del secolo scorso, un confronto che ha plasmato la nostra comprensione dell’universo, dal battito d’ali di una farfalla quantistica all’immensa danza delle galassie.
La Scintilla della Discordia: Un Universo Probabilistico o Deterministico?
Tutto iniziò con la nascita della meccanica quantistica, una teoria rivoluzionaria che descrive il comportamento della materia e dell’energia su scala atomica e subatomica. Niels Bohr fu uno dei suoi padri fondatori e il suo più strenuo difensore.
- La visione di Bohr e la Scuola di Copenaghen: Secondo Bohr, il mondo dell’infinitamente piccolo è intrinsecamente probabilistico e indeterminato. Non possiamo conoscere contemporaneamente con precisione assoluta certe coppie di proprietà di una particella, come la sua posizione e la sua quantità di moto (il Principio di Indeterminazione di Heisenberg). L’atto stesso di osservare il sistema ne influenza irrimediabilmente lo stato. La realtà a livello quantistico, per Bohr, esiste in uno stato di potenzialità (una “sovrapposizione di stati”) finché non viene misurata.
- La perplessità di Einstein: Albert Einstein, la cui Relatività Generale aveva descritto un universo maestoso, ordinato e governato da leggi precise e deterministiche, trovava questa nuova visione profondamente inquietante. La sua celebre frase “Dio non gioca a dadi” riassume perfettamente il suo scetticismo. Per Einstein, la probabilità nella meccanica quantistica non era una caratteristica fondamentale della realtà, ma piuttosto un segno dell’incompletezza della teoria. Credeva che esistessero delle “variabili nascoste”, delle proprietà ancora sconosciute che, se scoperte, avrebbero ripristinato un universo perfettamente prevedibile.
Il Cuore del Dibattito: Realismo e Località
La disputa si articolò in una serie di famosi “esperimenti mentali” proposti da Einstein per dimostrare le contraddizioni della meccanica quantistica, a cui Bohr rispondeva puntualmente, affinando la teoria.
Il culmine di questo scontro intellettuale fu il famoso articolo del 1935 di Einstein, Podolsky e Rosen (noto come paradosso EPR). Essi immaginarono due particelle “entangled” (intrecciate), generate dalla stessa sorgente e poi separate da grandi distanze.
- L’argomento di Einstein (il paradosso EPR): Secondo l’entanglement quantistico, misurare una proprietà di una particella (ad esempio lo spin) determina istantaneamente la proprietà corrispondente dell’altra, non importa quanto lontana sia. Per Einstein, questa “spettrale azione a distanza” violava il principio di località, un pilastro della sua teoria della relatività, secondo cui nessuna informazione può viaggiare più veloce della luce. Se la meccanica quantistica fosse completa, l’universo sarebbe “non-locale”. L’alternativa, per Einstein, era che le proprietà delle particelle fossero reali e predeterminate fin dall’inizio (un concetto chiamato realismo locale).
- La risposta di Bohr: Bohr ribatté che Einstein stava applicando concetti del mondo macroscopico (come la separazione e la località) a un regno, quello quantistico, dove non hanno lo stesso significato. Le due particelle entangled, secondo Bohr, dovevano essere considerate come un unico sistema quantistico, anche se separate da distanze cosmiche. La misurazione su una parte del sistema influenza istantaneamente l’intero sistema perché, in un certo senso, non è mai stato veramente separato.
L’Eredità della Disputa: Chi Aveva Ragione?
Per decenni, questa è rimasta una questione puramente filosofica. Poi, negli anni ’60, il fisico John Bell formulò un teorema (le disuguaglianze di Bell) che permetteva di verificare sperimentalmente chi avesse ragione.
Gli esperimenti condotti a partire dagli anni ’80, in particolare quelli di Alain Aspect, hanno dimostrato in modo conclusivo che le disuguaglianze di Bell sono violate. Questo significa che l’universo, a livello fondamentale, non è localmente reale come sperava Einstein. Le previsioni della meccanica quantistica, con la sua “spettrale azione a distanza”, si sono dimostrate corrette.
In un certo senso, Bohr ha avuto la meglio sul piano sperimentale. Tuttavia, la profonda intuizione di Einstein e le sue domande penetranti hanno costretto i fisici a interrogarsi sul vero significato della meccanica quantistica, spingendo la ricerca in nuove direzioni come l’informatica quantistica e la crittografia quantistica, che si basano proprio su quei fenomeni “strani” come l’entanglement.
In definitiva, la disputa tra Bohr ed Einstein non fu uno scontro tra giusto e sbagliato, ma un dialogo essenziale tra due diverse, profonde e feconde concezioni della realtà fisica. Un dialogo che, dalla comprensione dell’atomo, ha spalancato le porte a tecnologie rivoluzionarie e a una visione dell’universo più strana e meravigliosa di quanto chiunque avesse mai osato immaginare.