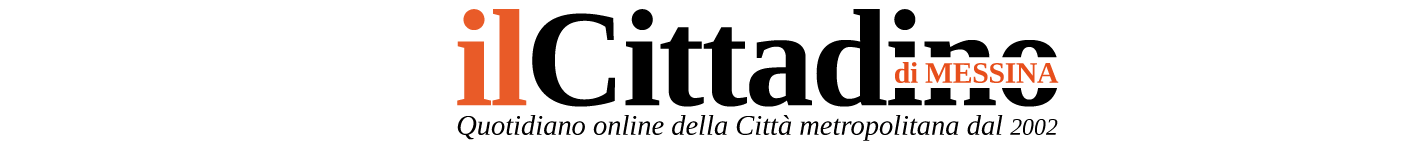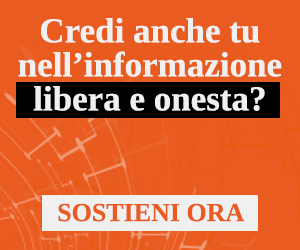L’importante documento del 1666 conservato presso L’Arca Magna (Archivio
Storico Capitolare) della Diocesi di Patti ci offre una lettura dettagliata e apre
molti scenari di ricerca sull’antico casale messinese di Castanea. Esso si
estendeva da Policara a San Saba, incluso Calamona, abbracciando tutto il
territorio dell’odierna Castanea fino a Portella e probabilmente, come
testimoniato da questo documento, vantava la giurisdizione spirituale su altre
chiese di cui una extra moenia intitolata a Santa Maria dei Bianchi (Alborum –
attigua alla contrada Ricciardo vi è la contrada Bianchi???) e l’altra a Santa
Maria di Trapani. Dal 1345 “una porzione” del vasto territorio era stata
venduta ai Gerosolomitani che rivendicavano anche la giurisdizione spirituale
sul restante casale generando continue liti e soprusi. Fra le tante motivazioni
di scontro forse quella più rilevante era l’elezione del parroco della
parrocchiale di San Giovanni che per “antico privilegio” veniva nominato dal
popolo che, quello stesso popolo, come si legge nell’epigrafe posta sulla
porta maggiore, nel 1500 aveva edificato il tempio dedicato anche al
Precursore. Dalla fine del XVI secolo prendevano avvio numerosi conflitti fra
la Curia arcivescovile di Messina e il Gran Priorato. Liti che spinsero la Santa
Sede a nominare per la chiesa di Castanea un vicario apostolico e a
dichiarare la stessa nel 1629 nullius dioecesis. Per anni toccò al vescovo di
Patti la nomina del vicario apostolico e per questo motivo ritroviamo fra le
varie relazioni delle visite pastorali quella di mons. Ignazio D’Amico che ebbi
modo di consultare nel 2018 e riprodotta in parte (facilmente reperibile in
rete) da Giovan Giuseppe Mellusi in “Archivio Storico Messinese”, Volume
104 (2023). Fra le tante notizie storico-artistiche e quelle inerenti ai toponimi
ancora oggi esistenti (da qui nasce l’accorato appello all’amministrazione
comunale di valutare l’importanza della toponomastica dei villaggi prima di
procedere senza tener conto che dietro vi è una memoria storica identitaria),
alle devozioni e alle tradizioni la preziosa relazione apre un campo di studi
vastissimo. Come già scritto delle ventuno chiese elencate nel documento ne
restano ancora due da identificare dopo che il tempio intitolato ai Santi Filippo
e Giacomo, sconosciuto da secoli, è stato localizzato. Il documento così ne
parla: «Visitavit ecclesiam Sanctorum Apostolorum Philippi et Iacobi dicti ruris
Castaneae que rettore caret et curam habuerunt patres fratres conventus
Ordinis Sancti Augustini huius ruris qui ad presens dictos conventus reperitur
oppressus, caret etiam omnibus iocalibus ecclesiae pertinentibus ad
celebrationem misse et comparuit fr. Ioannes huius ruris custos dicti
conventus dixit nichil haberet et curam gesserunt dicti patres Ordinis predicti
mandavit ut non celebretur in predicta ecclesia nisi prius compareant
habentes ius et causam coram Ill.ma et R.ma Dominatione Sua sopra
spatium diem quindecim et de omnibus ad predictam ecclesiam spettantibus
certiorem faciant ad effectum ut designetur persona que curam teneat de
preditta ecclesia de omnibus decenter ornetur et accommodetur» (vedi
Mellusi). La chiesa priva di rettore è affidata alle cure del convento annesso
alla chiesa dell’Annunziata dei Padri Agostiniani di Castanea che dal 1588
subentrarono alla confraternita dei Disciplinanti, quest’ultima presente alla
fine del XV secolo come attesta l’importante commissione fatta allo scultore
A. Freri per il gruppo marmoreo della titolare (oggi sono conservate le due
statue acefale). Il promontorio, ricco di uliveti e ville situato alle spalle della
baia di San Saba è denominato contrada San Filippo. Da anni interrogavo gli
anziani per ottenere eventuali notizie su una cappella dedicata a San Filippo
d’Agira a Castanea pensando che la contrada mutuasse il nome dal santo
esorcista venerato nella chiesa dell’Annunziata e festeggiato solennemente
nel XVII secolo. Di detto Santo conserviamo una statua lignea antica. Nella
prima domenica di questo mese, dopo pranzo, mi avventurai per le
campagne senza trovare nulla che mi riconducesse a un edificio di culto. Una
zona bellissima con un panorama mozzafiato, un terrazzo sul mare, una
“torre” pianeggiante di avvistamento che domina da Milazzo alla sponda
calabra, comprese le isole Eolie. Prima di tornare su per la collina raggiunsi la
costa, e mi fermai dinnanzi la seconda chiesa dedicata a San Saba nella
piazzetta adibita a centro di incontro. Qui chiesi agli anziani presenti notizie
ma nessuno mi seppe dare notizie in merito. Poi, una signora in villeggiatura
mi disse che nel suo podere proprio nella contrada dell’indagine, nell’antica
villa ereditata dai nonni, un tempo aveva trovato una “strana” pietra bianca
che era andata perduta. La invitai gentilmente ad accompagnarmi in questo
terreno che visitammo giorni dopo. Mi si presentò dinanzi un esteso uliveto
con una graziosa villa in rovina della fine del Settecento (?) con annesso
magazzino e con mia sorpresa mi fu detto, e poi documentato da alcuni scatti
fotografici, che ivi era stata rinvenuta una piccola campana in bronzo. Il
reperto non lasciava dubbi essendo datato al 1764 e ornato con due croci
inscritte in un cerchio in apertura e chiusura della data. Al centro in un tondo
nitide le figure di due santi quasi in un abbraccio mistico con due angeli in
volo che li incoronano. Sotto una siepe di pietre e infine tre putti oranti. Nel
ricercare l’iconografia dei santi apostoli Filippo e Giacomo il minore, ritratti e
festeggiati assieme dopo la traslazione delle loro reliquie avvenuta a Roma
nel 516 d.C., oltre la croce simbolo del martirio di Filippo, non mancano gli
angeli e le pietre che ricordano la lapidazione di Giacomo il minore. Il
ritrovamento di questa campana, custodita anticamente nel vecchio
magazzino, non lascia alcun dubbio: qui sorgeva la chiesa citata nella visita
pastorale nella vetusta Villa Maria di proprietà della famiglia Russo –
Giacoppo. Le dimensioni della campana, dal diametro di centimetri 25 e alta
30 centimetri, possono darci un’idea sul fabbricato che poteva essere non
dissimile per grandezza e conformazione alle sopravvissute chiese rurali dei
dintorni di Policara, Santa Rosalia, Tonnaro composte da un’aula rettangolare
coperta da volta a botte (impianti presumibilmente di epoca bizantina). Dal
promontorio in linea d’aria, si raggiunge con l’occhio l’altra chiesa dedicata a
San Domenico a Policara e quella sopra Rodia dedicata a Santa Maria del
Bosco, citate nella visita; queste tre insieme ad altre collocate a ritroso verso
la collina erano sicuramente avamposti, punti strategici di difesa dalle
incursioni che potevano sopraggiungere dal mare, i primi baluardi che via via
si trovano risalendo il torrente Giudeo fino alle porte di Castanea ultima
“roccaforte”, che proteggeva la città di Messina dalle probabili minacce che
sopraggiungevano dal Mar Tirreno. Rientrato a casa riprendo fra le mani il
prezioso volume di padre Ciraolo del novembre del 1908 e nel prestare
attenzione alle vergature, delle quali già scrissi nella mia pubblicazione, trovai
che la signorina Milena Ciraolo aveva scritto vicino alla descrizione della
chiesa di San Saba che: «Una chiesa vi era a Miano fatta nella proprietà di
Russo ora magazzino». La contrada Miano che in realtà coincide con torrente
omonimo è accostata alla contrada San Filippo e quel “magazzino” citato da
Milena è certamente quel vecchio magazzino annesso alla casina in cui fu
ritrovata la campana. Sempre in questa escursione un’altra importante
testimonianza, mentre cercavamo la chiesa, fu data da un naturale di San
Saba circa l’ubicazione della prima chiesa del Santo che Nino Principato, in
Sulle orme dei monaci bizantini a Messina del 2005, localizza addossata e
inglobata in un’abitazione in prossimità del ponte a mattoni (lato Rodia),
stesso luogo in cui il testimone racconta che il suo podere, che si trova sopra
la detta strada era denominato dalla sua trisavola “supra a chiesa” e che
Gaetano La Corte Cailler nel 1902 cosi descrive: “Andai a visitare la
chiesetta, proprietà della famiglia del Protopapa Vinci, il quale vi trasportò
una antica tavola della Madonna del Graffeo che era alla Cattolica. La chiesa
pare dell’istessa età di quella di Policara: è a volta ma con un arco
leggermente acuto.” “Ioseph Vinci Protopapa/Hic Jaceo/orate pro me 1772”:
questa era l’iscrizione posta sulla tomba della prestigiosa figura messinese
che volle essere sepolto nella chiesa del SS. Rosario di Castanea. Oggi un
frammento del sepolcro è esposto a lato destro della porta maggiore e di
recente mi è stato comunicato dal parroco di Castanea, don Vincenzo Majuri
che il Protopapa risulta essere stato battezzato in detta chiesa, dunque era
nato a Castanea!
Giovanni Quartarone