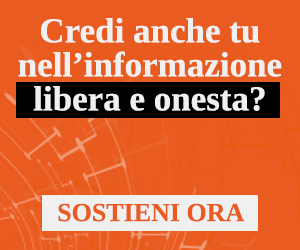In un Paese normale, quando un progetto pubblico mostra crepe antiche e costi fuori controllo, si ferma tutto e si ricomincia da capo. In Italia, invece, si preferisce trascinare l’errore fino alla fine, come se ammetterlo fosse più grave che commetterlo. Il Ponte sullo Stretto appartiene pienamente a questa categoria: un’opera concepita in un’altra epoca, con presupposti sbagliati allora e irreali oggi.
Il riesame richiesto dalla Corte dei Conti è un segnale, ma arriva tardi e rischia di essere solo un passaggio formale se non si ha il coraggio di guardare all’origine del progetto. Un’origine segnata da due scelte “non negoziabili”: una campata unica da record mondiale e una ferrovia inserita come dogma ideologico. Due decisioni che hanno trasformato un possibile ponte in un leviatano tecnico ed economico.
La verità è semplice: il ponte è stato pensato per costare molto. Una campata da 3.300 metri dove le torri devono obbligatoriamente stare a terra, quando altrove – Turchia e Giappone, zone sismiche per eccellenza – si mettono senza problemi in mare. E una ferrovia che, su una struttura del genere, impone pesi, vibrazioni, limiti di pendenza e richieste strutturali tali da far lievitare tutto. Sono scelte fatte per dire “il più grande del mondo”, non “il più adatto all’Italia”.
Sul fronte dei benefici economici, si è preferito proiettare scenari irrealistici piuttosto che leggere la realtà. Chi va da Palermo a Roma continuerà a prendere l’aereo, perché costa meno e impiega molto meno tempo. Le merci, da anni, scivolano sulle rotte marittime, non sulle autostrade del Sud. Messina e Reggio Calabria, con tutto il rispetto, non sono Copenhagen e Malmö, né hanno un retroterra industriale paragonabile.
Il ponte, semplicemente, non intercetta nessuno dei trend che dovrebbero giustificarlo. E non risolve nessun problema strutturale del Mezzogiorno.
Resta il nodo più sensibile: il debito pubblico. L’opera verrebbe finanziata interamente a debito, con la favola ricorrente secondo cui “tanto il rapporto debito/PIL scenderà grazie alla crescita”. Una visione ottimistica che il Paese smentisce ogni anno, con un’economia lenta e un debito oltre i 3.000 miliardi. È poco realistico pensare che venti miliardi “facciano poca differenza”: nella storia dei dissesti, il problema è sempre stata l’ultima goccia.
Siamo ancora in tempo. Si può dire “ci siamo sbagliati” e scegliere una strada diversa: un ponte autostradale leggero, meno costoso, costruibile in tempi rapidi e almeno in parte finanziabile dai pedaggi e dai privati. Non è una resa. È buon senso. E non è una scelta anti-ecologica: le auto saranno elettriche prima che il ponte attuale possa vedere la luce.
Il Paese ha bisogno di infrastrutture utili, non di monumenti all’ostinazione. L’Italia si misurerà con la sua maturità non da quanto è capace di progettare, ma da quanto è capace di fermarsi quando serve. E questa, oggi, è una di quelle volte.